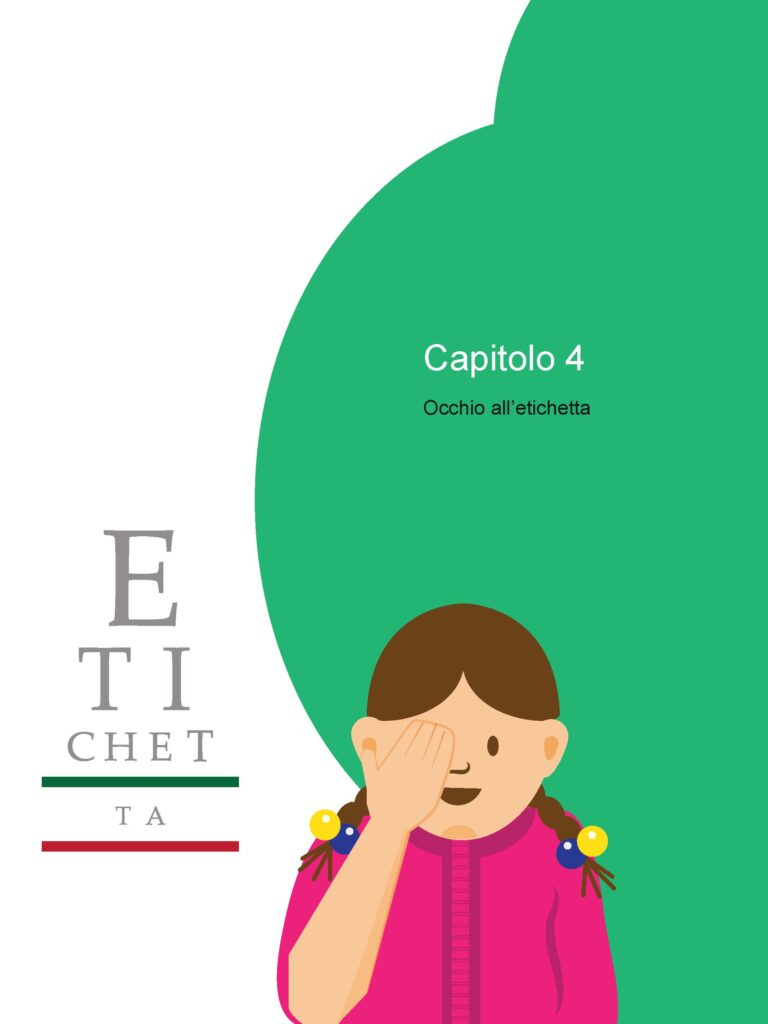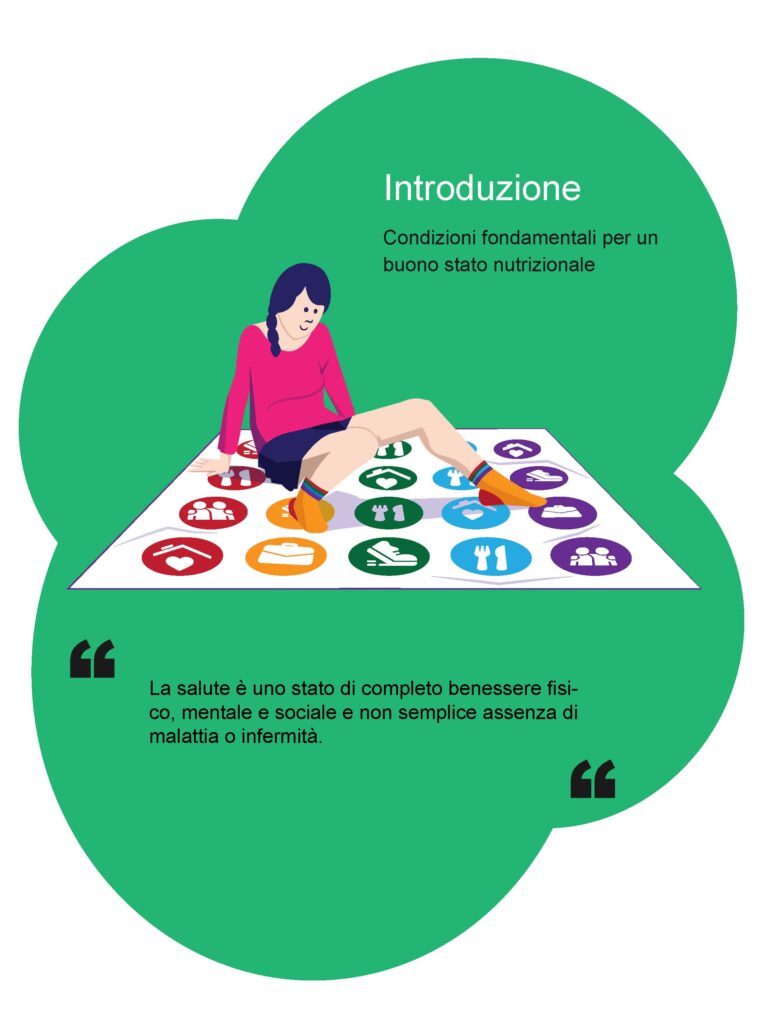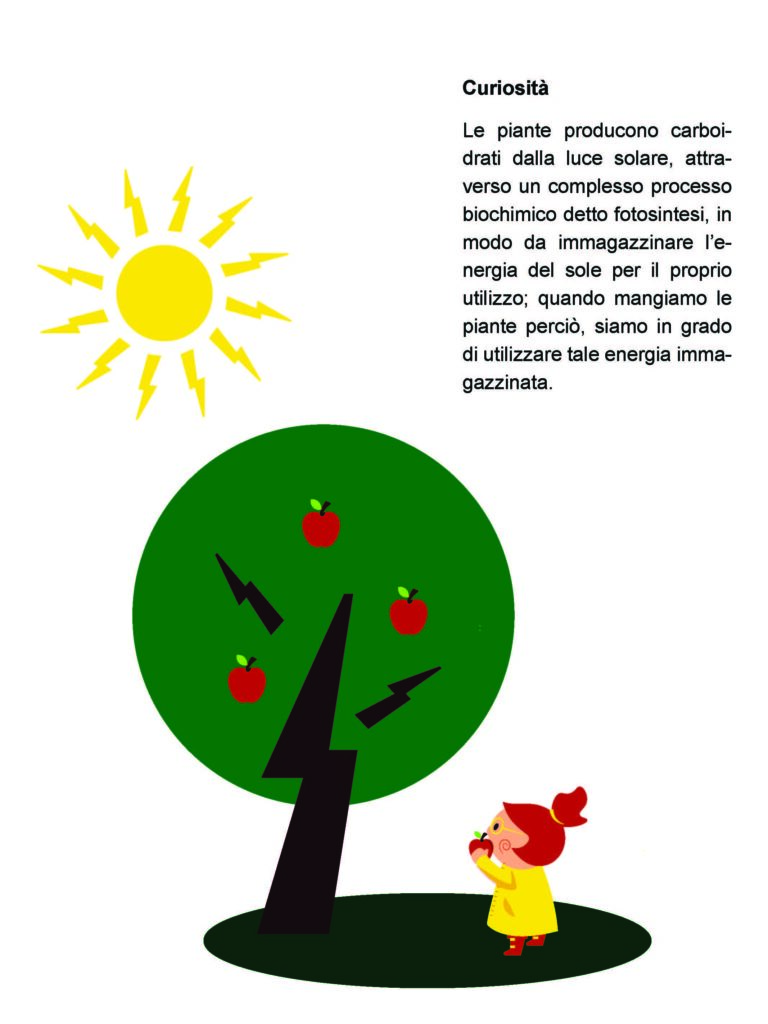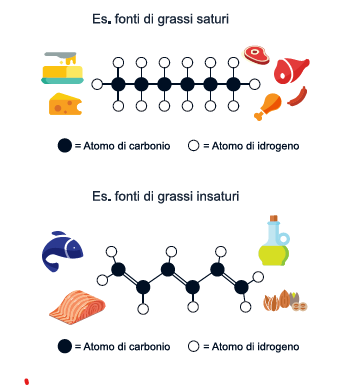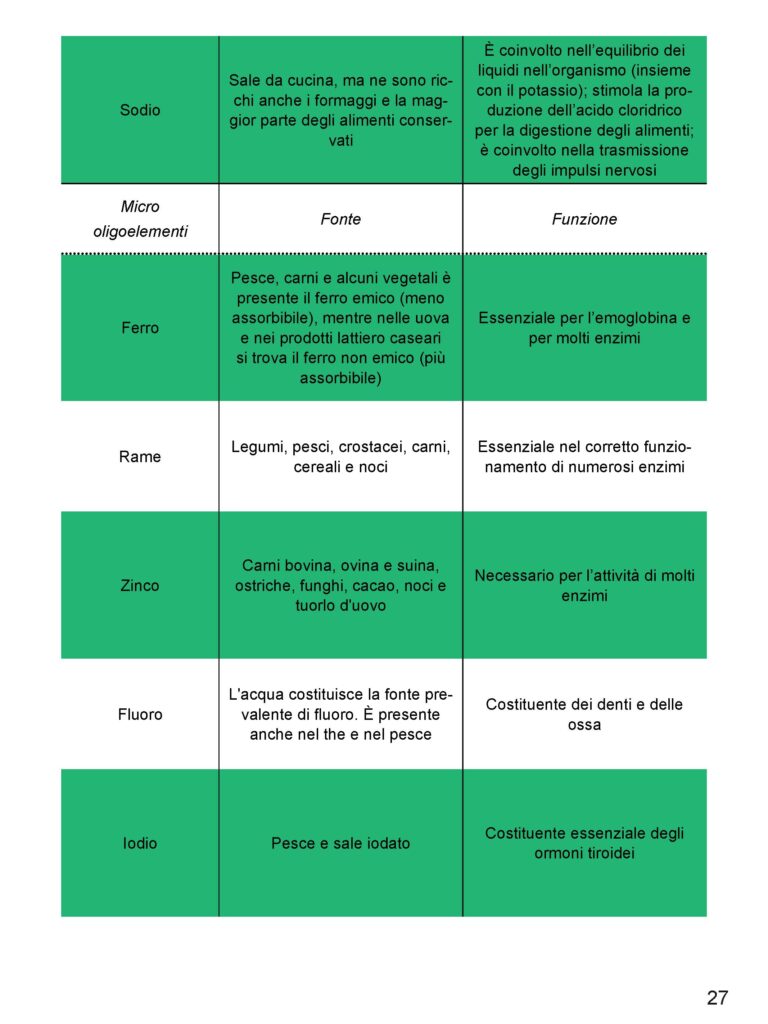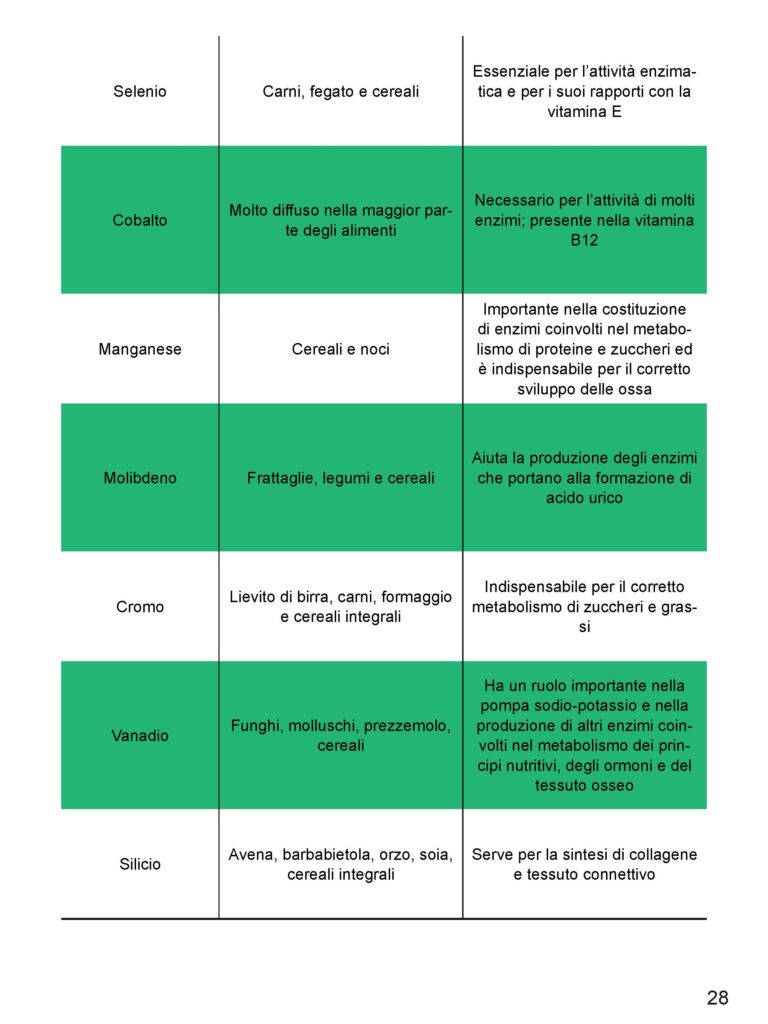La nutrizione giocando – La cottura dei cibi

La cottura è un procedimento che consiste nell’esporre il cibo a fonti di calore, con lo scopo di: aumentare la digeribilità dei cibi, alterarne la consistenza, arricchendoli di nuovi sapori, odori e colori, eliminare batteri, virus ed eventuali parassiti.
Se non eseguita correttamente, però, può non solo peggiorare il sapore di un cibo ma ridurne anche il valore nutrizionale, ad esempio portando alla perdita di alcune vitamine.
Per la sicurezza dei cibi, la cottura resta un procedimento di trasformazione delicato, in quanto se un alimento è cotto troppo poco si incorre nel rischio della presenza di batteri patogeni; al contrario, cuocere eccessivamente, arrivando alla bruciatura, comporta la formazione di sostanze potenzialmente dannose per la salute.
I metodi di cottura sono tanti e prevedono l’utilizzo di numerose fonti di calore. In generale si distinguono, per l’utilizzo o meno di acqua, in cottura in umido o a secco. La cottura in umido può essere fatta mediante bollitura, bagnomaria, a vapore o in pentola a pressione. I metodi a secco invece sono: cottura in forno elettrico, a gas o a legna, la frittura e l’arrostitura.
Nessun metodo di cottura può essere definito migliore di un altro, ognuno può essere utilizzato in maniera corretta secondo le precise metodiche e con gli utensili idonei, a seconda della ricetta, del tempo e delle circostanze. Ciò che è fondamentale ricordare per un corretto stile alimentare e una maggior tutela della salute è che le preparazioni derivanti da una cottura più “impegnativa” per il fegato, come può essere la frittura, vanno consumate con moderazione.
Principali metodologie di cottura:
Bollitura
È un metodo che consiste nell’immergere e cuocere gli alimenti in acqua o brodo bollente, consentendo di limitare di molto i grassi da condimento. Viene prevalentemente usata per cucinare alimenti quali verdure, legumi, pasta, riso, patate ma anche per pesce, carne e uova. Con la classica pentola tradizionale possiamo cuocere al massimo alla temperatura di ebollizione dell’acqua (100°C circa); per ridurre i tempi di cottura è possibile usare invece la pentola a pressione, che consente di raggiungere temperature più alte, anche 120°C circa.
Dal punto di vista nutrizionale questo metodo di cottura consente di limitare molto l’utilizzo di grassi da condimento e di aromatizzare gli alimenti con l’aggiunta di odori e spezie. A seconda dell’alimento è necessario impiegare una diversa quantità di acqua e un tempo di cottura diverso: per verdure e legumi è meglio utilizzare il minor quantitativo possibile di acqua, in modo da ridurre al minimo le perdite di vitamine; questo aspetto, invece, è meno importante per zuppe o bolliti di carne o pesce perché il brodo e i nutrienti in esso disciolti vengono normalmente consumati.
Più la cottura è lunga, maggiore è la perdita di vitamine. Per questo è preferibile immergere gli alimenti in acqua già bollente.
Cottura al Vapore
La cottura al vapore consiste nel mettere gli alimenti a contatto diretto con il vapore senza immergerli in acqua, con l’utilizzo di apposite pentole, evitando l’uso di grassi da cottura. Verdure, pesci e crostacei sono gli alimenti più indicati per la cottura al vapore.
Questo genere di cottura non comporta perdite significative di nutrienti e spesso anche le caratteristiche organolettiche dell’alimento, come il sapore e la consistenza, risultano più salvaguardate.
È tuttavia preferibile cuocere solo alimenti tagliati in piccoli pezzi o fette, perché altrimenti i tempi di cottura sarebbero troppo lunghi.
È la cottura che preserva maggiormente i sapori e, contrariamente all’immaginario comune, la cottura al vapore non è sinonimo di mancanza di gusto in quanto i cibi possono essere posti in cartocci e conditi con spezie, erbe e un filo d’olio extravergine d’oliva.
La cottura al vapore è il metodo che mantiene maggiormente integre le vitami-ne; quanto alle sue virtù dietetiche, valgono solo se non si esagera con i condimenti.
Cottura a microonde
Il forno a microonde è un forno in grado di cuocere completamente gli alimenti, oltre che riscaldarli o scongelarli.
Il flusso di microonde generato all’interno dell’elettrodomestico agita le mole-cole d’acqua contenute negli alimenti. Il calore quindi si trasmette dall’interno dell’alimento verso l’esterno. Per questo motivo a volte i cibi cotti al microonde sono tiepidi alla superficie e caldissimi all’interno.
Usare questo tipo di cottura permette di dimezzare i tempi, ridurre al minimo le perdite di sostanze nutritive e l’aggiunta di condimenti; tuttavia non è possibile cucinare alimenti di grossa pezzatura, perché le onde elettromagnetiche riesco-no a penetrare la superficie al massimo di 4/5 centimetri.
Il microonde non aggiunge niente di particolare sul versante sapore. Si usa soprattutto per riscaldare gli alimenti.
Il calore intenso e rapido di questa cottura conduce a perdite di vitamine e minerali, che interessano soprattutto la vitamina C.
Griglia e piastra
La cottura alla griglia avviene per irraggiamento: il calore si trasmette senza che vi sia un diretto contatto tra l’alimento e la fonte di calore. La cottura alla piastra, invece, avviene per contatto: gli alimenti vengono fatti aderire direttamente alla piastra arroventata.
Entrambe queste modalità di cottura possono bruciare in superficie gli alimenti, formando sostanze potenzialmente dannose o cancerogene.
Alcuni esempi sono la carne alla brace o la pizza e i prodotti cotti con il forno a legna. Le parti carbonizzate, che a volte si formano per un eccesso di cottura, potenzialmente contengono le sostanze sopracitate e, quindi, è meglio scartarle.
È consigliabile accompagnare i cibi cotti alla brace con molti ortaggi freschi e il succo di limone, notoriamente ricchi di antiossidanti.
Entrambi i metodi di cottura portano alla totale distruzione di vitamine e minerali, quando la cottura è prolungata.
Frittura
La frittura consiste nell’immergere e cuocere gli alimenti in grassi animali o oli vegetali che non dovrebbero raggiungere il “punto di fumo”. Il punto di fumo è rappresentato dalla temperatura in cui il grasso inizia a bruciare e a decompor-si, formando sostanze tossiche; questo momento è visibile anche a occhio nudo perché il grasso riscaldato inizia a rilasciare del fumo vero e proprio. Non tutti gli oli e grassi hanno lo stesso punto di fumo, ad esempio l’olio di arachidi e l’olio di oliva hanno punti di fumo più alti rispetto agli oli di semi.
Gli alimenti fritti sono molto grassi, soprattutto quando sono circondati da una pastella che si impregna di olio. Come la brace, anche la frittura distrugge le vitamine. È un metodo di cottura di cui non fare uso quotidianamente.